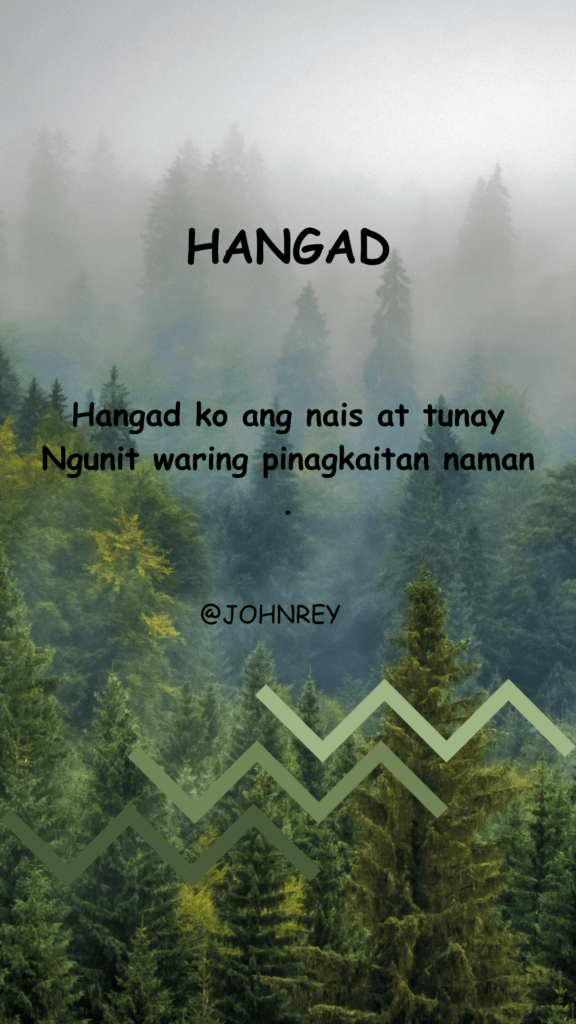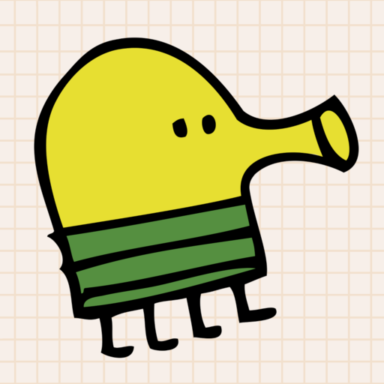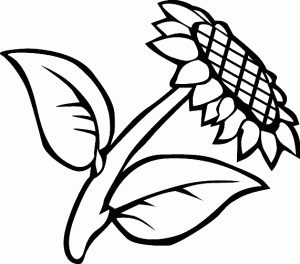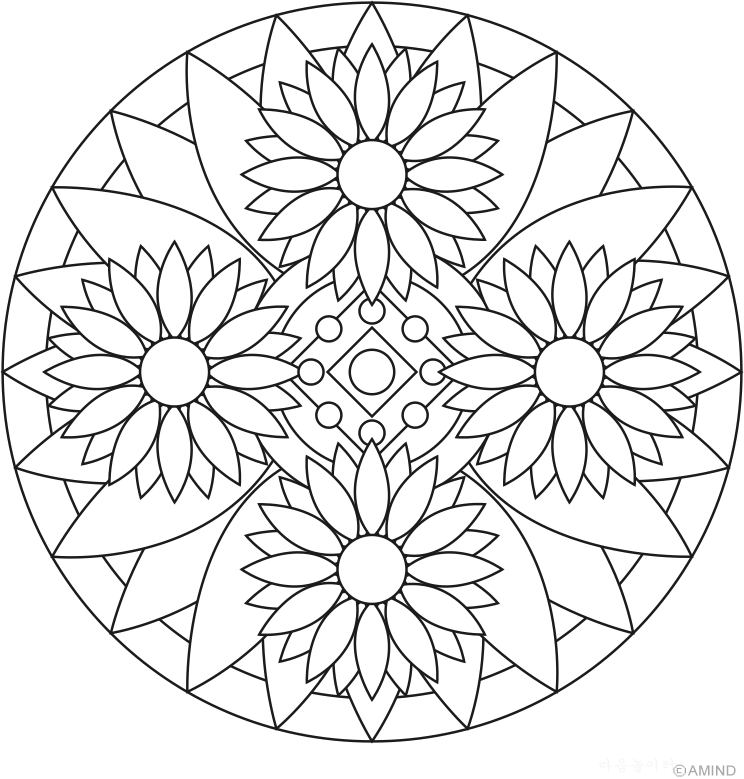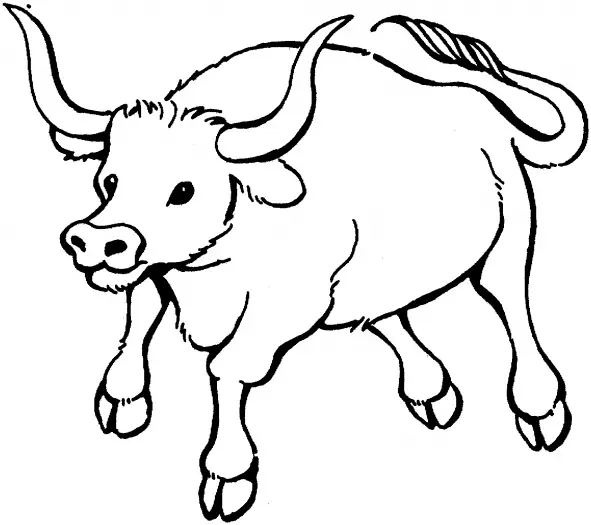Questo pezzo è uscito sul numero 9/2013 di MicroMega. Da venerdì riprendiamo il diario di Giuliano Battiston da Kabul. (La foto è di Giuliano Battiston.)
In Afghanistan la guerra dura ormai da dodici anni. Alcune settimane fa è entrata nel suo tredicesimo anno di vita, celebrato con l’ennesimo, triste record di vittime civili. Il paese attraversa uno dei periodi più delicati della sua storia recente, la transizione (Inteqal), il processo con cui la responsabilità della sicurezza viene trasferita dalle forze internazionali a quelle afghane. A un anno dal compimento della transizione, che avverrà alla fine del 2014, è tempo di tirare le somme: sul piano militare, gli americani e le forze che fanno capo alla missione Isaf-Nato sono stati sconfitti; sul piano simbolico, la comunità internazionale ha sperperato l’intero capitale politico di cui godeva nei primi anni post-talibani.
Per questo, nelle cancellerie occidentali oggi non si discute più di come conquistare i cuori e le menti della popolazione, ma di come girare i tacchi senza perdere del tutto la faccia, mentre nelle città afghane non ci si chiede più quali benefici porteranno gli stranieri, ma cosa avverrà una volta che avranno lasciato il paese. Agli stranieri basterà prendere in mano le valigie e abbandonare l’Afghanistan con la stessa facilità con cui è stato occupato nel 2001. Gli afghani dovranno invece restare e affrontare un futuro incerto. Per cercare di capirne qualcosa di più, abbiamo adottato una chiave di lettura “interna”, analizzando i punti di forza e di debolezza dei tre principali attori dello spettro politico e sociale afghano: i Taliban, il governo, la società civile.
I Taliban
Tattiche e strategie. A dodici anni dall’avvio dell’intervento militare in Afghanistan, il principale gruppo antigovernativo – i Taliban – risulta militarmente e politicamente più forte di allora. Dal punto di vista della tenuta territoriale, gli strateghi dei ‘turbanti neri’ sono riusciti a trasformare un elemento di debolezza – la crescente pressione militare subita nel sud del paese – in un pretesto per espandersi progressivamente nel nord (a partire dal 2006) e ad est, nella zona di confine con il Pakistan (soprattutto a partire dal 2010). Ciò rivela la flessibilità strategica dei Taliban, capaci di adattare le tattiche militari a un mutato contesto di guerra. Un’abilità dimostrata da almeno un altro elemento: il tentativo, avviato nel 2008, di rivedere la forma organizzativa del gruppo, incrementando il controllo centralizzato sulle unità di combattimento locali e favorendo il coordinamento interno.
Questo sforzo ha portato all’apertura di una vera e propria Commissione militare a Peshawar, in Pakistan, con il compito di coordinare le attività delle unità di combattimento. E ha dato vita a un processo ancora in corso: la transizione da un tipo di guerriglia decentralizzata, basata sul “franchising” del marchio talibano, a una guerriglia centralizzata, gestita in modo più “burocratizzato”. Gli esiti di questo processo sono difficili da prevedere, anche perché ha già provocato un dissidio tra la direzione politica (la shura di Quetta, riconducibile alla vecchia guardia e alla leadership storica del mullah Omar), e la nuova direzione militare (la shura di Peshawar, che gestisce la strategia nel breve termine, più vicina ai servizi segreti pakistani). La decisione di avviare una simile rivoluzione strutturale dimostra comunque che i Taliban guardano al futuro, non al passato. Non sono una forza residuale, ma un gruppo consapevole delle proprie potenzialità.
I successi politici. Un gruppo che ai successi strategici somma quelli politici: deboli, divisi e sfiduciati all’inizio del 2002, a dispetto dei dissidi interni e grazie agli aiuti esterni oggi i Taliban possono rivendicare di essere l’unico “vero, partito di opposizione in Afghanistan”, come sostiene Antonio Giustozzi[1], tra i più autorevoli studiosi della galassia talibana. Politicamente, il loro maggiore successo è l’essere riusciti a sedersi al tavolo negoziale in una posizione di forza. Anzi, il fatto stesso di essere riusciti a far digerire perfino agli americani l’idea che l’opzione militare è ormai impraticabile e che l’unica opzione è quella politico-diplomatica: fino a pochi anni fa soltanto dei “terroristi”, oggi i Taliban godono di una patente di legittimità politica. Ad attribuirgliela, sono stati proprio gli americani. Lo dimostra l’apertura lo scorso giugno del loro Ufficio politico di rappresentanza a Doha, in Qatar. Fortemente voluta dagli statunitensi, dai tedeschi e dalla monarchia qatarina e altrettanto fortemente contestata dal presidente Karzai, l’apertura dell’Ufficio indica due aspetti centrali, ormai inconfutabili, esposti con la consueta chiarezza dallo studioso Gilles Dorronsoro in uno dei suoi ultimi lavori, Waiting for the Taliban in Afghanistan[2]: “la coalizione non può più sconfiggere i Taliban, che rimarranno una forza politica e militare in Afghanistan nel prossimo futuro […] Date le circostanze, gli Stati Uniti devono cominciare a considerare la situazione che si creerebbe con la caduta del regime e il ritorno dei Talebani al potere”.
Taliban di nuovo al potere? L’idea del ritorno dei Taliban al potere potrà scandalizzare qualcuno, ma quando si parla di processo di pace, di negoziato, è di questo che si discute: di quale forma assumerà il sistema politico afghano in futuro, e, dunque, di quanto potere avranno i Taliban: l’ipotesi di un governo di ‘ampia coalizione’ – al cui interno figurino esponenti del movimento talebano – non è affatto remota. Lo sanno bene gli afghani e lo sanno ancora più chiaramente i Taliban. Anche per questo il mullah Omar ha cominciato ad assumere una postura da futuro capo di Stato (o comunque da leader nazionale), tenendo discorsi politici a tutto tondo. Come quello scritto in occasione delle celebrazioni per la fine del Ramadan e affidato alla propaganda virale del sito dell’Emirato islamico d’Afghanistan, Voice of Jihad. In quell’occasione, da veterano della comunicazione politica, il leader degli studenti coranici ha adottato un doppio registro: internamente, ha rivendicato una politica unitaria e moderata; ha rassicurato le etnie minoritarie (i Taliban sono un movimento di matrice pashtun, maggioritaria nel paese); ha ribadito che i Taliban “non hanno intenzione di monopolizzare il potere”; ha parlato di un “sistema inclusivo” e garantito che, dopo il ritiro degli stranieri, “non ci saranno rappresaglie”, per poi invitare al boicottaggio delle elezioni presidenziali che si terranno ad aprile 2014 (“una perdita di tempo decisa dagli americani”).
Esternamente, ha ammonito gli americani dall’evitare una presenza militare prolungata nel paese; ha sbandierato i successi strategici della campagna militare di primavera Khaled Bin Waleed, inaugurata il 28 aprile; ha aperto in modo esplicito sull’educazione “moderna”, definita “un bisogno fondamentale di ogni società nei tempi attuali”; ha sottolineato che il teatrino dei negoziati di pace è inutile, perché l’unico vero obiettivo è “la fine dell’occupazione”. Soprattutto, ha rinnegato ancora una volta i legami con l’universo qaedista, ribadendo che i Taliban non intendono “danneggiare nessuno, né permettere a nessuno di danneggiare gli altri dal loro territorio”.
La forza dei Taliban è la debolezza del governo. Il suo discorso ha rassicurato gli ambienti diplomatici di Kabul, dove le valigie sono pronte da tempo per il ritiro, ma non ha affatto convinto la maggioranza degli afghani, soprattutto quelli che vivono in città, per i quali l’ipotesi di un governo di ampia coalizione suscita forti preoccupazioni. Ed è questo il vero punto debole dei Taliban: resistenti sul campo di battaglia, forti al tavolo negoziale, finanziariamente solidi grazie al sostegno di diversi paesi stranieri, appaiono fragili in casa, in termini di consenso. Se in alcune aree rurali godono di un appoggio logistico e dell’adesione ideologica della popolazione, altrove sono guardati con sospetto: troppo pesante l’eredità del loro governo, troppo pesante il bilancio delle vittime civili da loro provocate, troppo lontani dal sentire comune le loro idee sull’economia e sulla società.
Il mullah Omar ha cercato di rivedere alcuni punti programmatici, stilando un nuovo codice di condotta dei guerriglieri e – come abbiamo visto – mostrandosi più aperto sui temi dell’educazione, ma il sospetto rimane. La domanda da porsi allora è la seguente: perché, nonostante il sospetto nei loro riguardi, i Taliban rimangono un attore fondamentale nel panorama politico afghano? Per due motivi. Perché la presenza delle truppe straniere è di per sé un fattore di mobilitazione antigovernativa, un carburante per la macchina della propaganda jihadista. E perché il governo afghano è del tutto screditato e ormai privo di ogni legittimità agli occhi della popolazione. In altri termini, la vera forza dei Taliban è la debolezza del governo.
Il governo afghano
Il deficit di fiducia verso il governo
Chiunque si prenda la briga di viaggiare in Afghanistan, se ne accorge presto: il deficit di fiducia nei confronti del governo e delle istituzioni è uno degli elementi che più alimentano la mobilitazione antigovernativa. Secondo le interviste raccolte da chi scrive in 7 diverse province afghane nel corso di cinque mesi di ricerca[3] per il network “Afgana” (www.afgana.org), il governo è percepito come totalmente illegittimo, perché impermeabile alle richieste dei cittadini, incapace di provvedere ai loro bisogni essenziali, corrotto, animato da interessi egoistici e predatori. Alla base del conflitto afghano c’è dunque anche il profondo divario tra il governo e la popolazione, che diffida di un sistema incapace di sconfiggere i gruppi ribelli, garantire la sicurezza ai cittadini, assicurare la pace nel paese. Il primo punto – la “tenuta” dei ribelli – lo abbiamo già analizzato. Quanto al secondo, bastano i dati dell’ultimo rapporto semestrale sulla protezione dei civili in Afghanistan pubblicato da Unama, la missione dell’Onu in Afghanistan: nei primi mesi del 2013 c’è stato un aumento del 23% delle vittime e dei feriti tra la popolazione civile, rispetto al 2012. Sul terzo punto, quello relativo al processo di pace, al governo viene contestato un metodo di lavoro troppo opaco e l’assenza di una reale strategia su quali debbano essere gli esiti del negoziato, su quanto e quale potere debba essere accordato ai movimenti antigovernativi e sul come cederlo senza che il governo perda la residua legittimità istituzionale e politica.
L’ingiustizia: corruzione e cultura dell’impunità
Il sentimento di sfiducia verso il governo è crescente, ed è riconducibile a un diffuso senso di ingiustizia. Per “ingiustizia”, gli afghani intendono molte cose: la mancanza di giustizia penale e dello stato di diritto; l’ingiustizia sociale; l’ineguale distribuzione delle risorse e del potere politico ed economico; la mancanza di servizi sociali e di opportunità di lavoro. Sono due però i fattori su cui tutti, unanimemente, insistono: la corruzione e la cultura dell’impunità. Per gli afghani, la corruzione è infatti uno dei pericoli maggiori per la stabilità del paese e uno degli ostacoli verso la stabilizzazione, perché – diffusa e capillare – mina alle fondamenta la legittimità del governo.
I numeri confermano le percezioni: nel 2012, la metà dei cittadini ha pagato una mazzetta per richiedere un servizio pubblico, mentre il costo totale della corruzione è arrivato nel corso dell’anno a 3.9 miliardi di dollari, secondo le stime di Corruption in Afghanistan. Recent Patterns and Trends, un rapporto realizzato dall’Ufficio anticorruzione afghano (High Office for Oversight and Anticorruption, HOO) insieme allo United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Sulle cause della corruzione, vale la pena aggiungere due elementi: il primo è che gli afghani rigettano l’accusa che si tratti di una pratica endogena. Piuttosto, considerano gli internazionali responsabili: la quantità di aiuti erogati, ma soprattutto i meccanismi della loro distribuzione e assegnazione, eccederebbero la capacità di assorbimento complessivo della società e le capacità di gestione delle istituzioni. Ecco la seconda considerazione. Per molti, la corruzione dipende dal repentino passaggio da un sistema economico fortemente burocratizzato, di derivazione sovietica, a un sistema basato sull’economia di mercato: l’apertura improvvisa al sistema del libero mercato in un paese privo di adeguate strutture istituzionali di controllo e di indirizzo delle politiche economiche avrebbe generato la corruzione. Alla cui origine ci sarebbe l’idea contraddittoria di costruire un nuovo stato con i soldi dell’aiuto allo sviluppo, senza un contestuale rafforzamento del quadro istituzionale.
I signori della guerra: il potere istituzionalizzato dalla comunità internazionale
Anche per la diffusione della cultura dell’impunità, gli afghani puntano il dito verso gli stranieri, soprattutto a causa del sostegno accordato ai “signori della guerra”, formula generica ma efficace per descrivere quei leader politici e militari che prima hanno sventrato il paese e poi, grazie al sostegno della comunità internazionale, hanno istituzionalizzato il proprio potere. Anziché favorire un cambio di leadership e rimuovere dal potere quanti in passato si sono macchiati di crimini di guerra o hanno compiuto abusi dei diritti umani, la comunità internazionale ha preferito adottare una spregiudicata politica di cooptazione: oggi a detenere il potere politico, economico e militare sono proprio i leader considerati più corrotti e violenti dalla popolazione. In una situazione simile, aspettarsi che gli afghani sostengano le istituzioni post-talebane sarebbe ingenuo. Quel che gli afghani sostengono è invece un processo che accerti la verità sui crimini passati e che conduca a un rinnovamento del quadro politico.
Nell’attuale contesto, entrambi sono processi titanici e, insieme, necessari: necessari perché a gravare sul conflitto di oggi è l’eredità di quelli precedenti. Titanici perché, anche se hanno dismesso le uniformi militari sostituendole con il doppiopetto, anche se i loro kalashnikov sono più silenziosi e meno esibiti di prima, i signori della guerra non sono meno pericolosi, potenti e temuti. Ma sono processi titanici soprattutto perché manca la volontà politica di fare i conti con il passato, sia da parte del governo afghano, sia da parte della comunità internazionale. Lo dimostra il caso del “Conflict Mapping Report”, il rapporto realizzato dalla Commissione indipendente dei diritti umani che da mesi il governo Karzai impedisce di rendere pubblico. Il dossier, ci ha spiegato nel suo ufficio di Kabul Sima Samar, la portavoce della Commissione, “individua gli abusi compiuti in passato” e “viene incontro alle richieste di giustizia della popolazione, già emerse al tempo del nostro sondaggio A Call for Justice, del 2005. Da allora, ci siamo impegnati a lavorare all’Action Plan per la Transitional Justice, ma abbiamo potuto realizzare solo alcuni punti del piano, a causa del mancato impegno da parte del governo e a causa del disinteresse della comunità internazionale”. Per Sima Samar, “entrambi hanno preferito lavarsene le mani, pensando che la questione della giustizia si esaurisse con la rimozione dei Taliban dal potere”.
Volti noti, alle prossime elezioni presidenziali
La rimozione dei Talebani dal potere non ha però esaurito la questione della giustizia. Né lo potranno fare le elezioni provinciali e presidenziali che si terranno il prossimo 5 aprile, quando gli elettori dovranno scegliere il sostituto di Hamid Karzai, il cui secondo mandato è in scadenza. Le elezioni del 5 aprile sono fondamentali. “Il vero evento politico spartiacque per l’Afghanistan saranno le elezioni del 2014”, e “il verdetto sulla guerra in Afghanistan potrebbe essere scritto meno sui campi di battaglia che negli uffici elettorali della prossima primavera”, hanno scritto pochi mesi fa l’ex comandante della missione Isaf in Afghanistan, il generale John Allen, l’ex sotto-segretario alla Difesa americano, Michèle Flournoy e Michael O’Hanlon – Senior Fellow alla Brookings Institution – nel saggio Toward a Successful Outcome in Afghanistan (Center for a New American Security). Quale che sia il verdetto delle urne, la popolazione appare sfiduciata. Tutti si augurano un profondo rinnovamento del quadro politico-istituzionale, ma nessuno crede davvero che possa accadere. Non ora. Non con questi candidati. Non con politici che hanno alle spalle simili curricula. L’alleanza tra il tecnocrate Ashraf Ghani e il generale Dostum esemplifica bene il vicolo cieco della politica afghana. E la sfiducia che genera tra la popolazione.
Lo strano sodalizio tra il tecnocrate e il generale dalle mille alleanze
Ashraf Ghani è il candidato che piace agli stranieri, soprattutto agli occidentali, perché incarna il volto dell’Afghanistan che molti vorrebbero: liberale nei modi, liberista in economia, libero dal conservatorismo culturale di molti afghani. Ha vissuto per 24 anni fuori dal paese, ha studiato alla Columbia University, lavorato per la Banca Mondiale, scritto un libro (Fixing the Failed States) sui processi di ricostruzione dei paesi in stato di crisi. Rientrato in Afghanistan, è stato rettore dell’Università di Kabul, ministro delle Finanze nel primo governo ad interim di Karzai, che poi gli ha affidato il compito cruciale di gestire la complicata fase della transizione. Piace molto agli afghani educati, a quanti hanno studiato e vivono nelle città principali, molto meno a quel 70% di popolazione che vive nelle aree rurali (alle presidenziali precedenti ha ottenuto il 2.9%). Negli ultimi anni ha fatto di tutto per dimostrare che, a dispetto di tutto, anche lui è un afghano come gli altri, e ormai non c’è occasione pubblica in cui non sfoggi un bel turbantone in testa, come a dire che è un pashtun d’origine controllata. Forse riuscirà a vincere la diffidenza sul suo lungo soggiorno all’estero. Più difficile che riesca a vincere la diffidenza di chi critica la sua decisione di scegliere come vice-presidente Abdul Rashid Dostum.
Generale dalle mille alleanze, tra i più spietati comandanti nel periodo della guerra civile tra mujaheddin (1992-1996), fondatore del partito Jombesh-e-Melli (National Islamic Movement of Afghanistan), Dostum ha dominato a lungo con mano pesante il suo personale feudo settentrionale, nelle province di Balkh, Jowzyan, Sar-e-pul, Faryab, abitate soprattutto da tajiki, che per il voto guardano altrove, e uzbeki, il suo bacino elettorale. Costretto a scappare in Turchia nel 1997 sotto pressione dei Taliban, è stato uno dei signori della guerra su cui gli americani hanno fatto affidamento per “liberare” il paese dai turbanti neri, nel 2001. Ashraf Ghani l’ha voluto per rafforzare la propria candidatura e prendere voti anche nelle province settentrionali. Che gli riesca o meno, rimane un fatto: anche il tecnocrate illuminato è dovuto scendere a patti con un signore della guerra con le mani sporche di sangue, come testimoniano le denunce di Human Rights Watch e Amnesty International. Il patto tra il tecnocrate e il generale dalle mille alleanze ci dice una cosa: la politica afghana è ancora in balia dei criminali di guerra, nonostante le promesse di dodici anni fa sulla democrazia da esportazione e sul rafforzamento della società civile, che appare stretta tra due fuochi: da un lato un governo corrotto e inefficiente, sostenuto da una comunità internazionale distratta quanto basta per legittimare il potere dei criminali di guerra; dall’altro un fronte antigovernativo che non esita a uccidere i civili per cacciare l’invasore infedele. In una situazione simile, quale ruolo può assumere la società civile?
La società civile afghana
L’interpretazione burocratica della società civile[4]
Per rispondere a questa domanda, per prima cosa è indispensabile capire cosa si intende per società civile, e cosa può significare un concetto simile in un contesto come quello afghano, dove il sistema politico-sociale opera secondo meccanismi differenti da quelli che hanno dato vita agli Stati-nazione europei (nel cui ambito è stata sviluppata la nozione classica di società civile). Se negli Stati-nazione prevale la corrispondenza tra autorità politica, sovranità giuridica e confini territorialmente definiti, in Afghanistan esiste invece una differenza tra sovranità formale e sovranità reale, tra autorità de jure e autorità de facto, con una centralizzazione statale che si combina storicamente a una frammentazione centrifuga del potere, distribuito tra una varietà di attori locali e regionali.
A dispetto di questa diversità, sin dal trattato di Bonn del 2001 (che ha delineato il quadro della transizione post-talebana), tutti i principali paesi donatori hanno accordato alla società civile un ruolo centrale nei processi di peace-building e di ricostruzione. Il guaio è che si è trattato di un sostegno perlopiù formale, basato su una concezione miope e riduttiva di società civile. I paesi donatori hanno infatti sostenuto soprattutto le organizzazioni formalmente istituite, le Ong in primo luogo, perché percepite come politicamente neutre e più efficaci nel raggiungere i beneficiari dei loro progetti. La preferenza accordata alle Ong e alle associazioni inclini a sottoscrivere l’agenda e l’orientamento politico dei paesi donatori – quella che è stato definita “l’interpretazione burocratica della società civile” – non riguarda infatti solo l’Afghanistan. È invece un fenomeno caratteristico del connubio stabilito a partire dagli anni Novanta nelle politiche allo sviluppo tra l’agenda della “good governance” e la progressiva riaffermazione del discorso sulla società civile. È allora che, sulla spinta dell’ideologia neoliberista, si è cercato di liberare lo Stato dalla sua responsabilità nei confronti dei cittadini. Ed è allora che le funzioni e i servizi della macchina burocratica statale, considerata inefficace ed elefantiaca, sono stati trasferiti alle Ong, giudicate più flessibili, capaci di attuare politiche di compensazione sociale senza sollevare obiezioni politiche.
Come altrove, anche in Afghanistan ne è derivata una semplice equivalenza tra società civile e organizzazioni non governative (le forme associative più familiari dal punto di vista occidentale, quelle più strumentali all’agenda della “good governance”), insieme all’idea che, erogando soldi per le politiche di aiuto umanitario, si sarebbe di per sé sostenuta la società civile, ridotta dunque a semplice erogatrice di servizi. A farne le spese sono state le forme locali di associazionismo, come i gruppi culturali, le shura e le jirga (i consigli locali), organizzate secondo criteri diversi da quelli propri della concezione liberale della società civile. Ma a farne le spese è stata anche l’idea della società civile come attore dell’agone politico, agente di cambiamento e di conflitto. Si tratta di un processo storico ancora in corso, le cui conseguenze appaiono comunque già evidenti: a uno Stato rentier, è stata affiancata una società civile rentier, donor-driven, sostanzialmente dipendente dalle risorse esterne.
Alcuni dati, anche se generali, ci aiutano ad avere un’idea del fenomeno: secondo le stime della Banca mondiale, tra il 90 e 95% del prodotto interno lordo afghano dipende dall’aiuto esterno. L’economia nazionale in questi anni è cresciuta a ritmi invidiabili, intorno al 9-10% annuo e con un aumento del Pil del 79% in pochi anni, ma rischia di collassare, con l’inevitabile, fisiologica diminuzione della mole di aiuti, dopo il ritiro dei soldati previsto alla fine del 2014. I precedenti sono chiari, e dimostrano che gli aiuti umanitari sono il braccio destro dell’interventismo militare: una volta che i soldati vengono ritirati, si chiudono anche i rubinetti degli aiuti. Il ritiro della Nato dalla Bosnia nel 2004, per esempio, ha fatto scendere il volume degli aiuti da un massimo del 57% del Pil nel 1995 all’8% del 2004. Anche per questo gli afghani hanno accolto come una boccata d’ossigeno – momentanea – l’impegno assunto dai donatori alla conferenza di Tokyo del luglio 2012, quando la comunità internazionale si è impegnata per 16 miliardi di dollari in aiuti fino al 2016-17. Ma la questione rimane: l’economia afghana dipende dagli aiuti esterni; gli aiuti esterni sono destinati inevitabilmente a diminuire; con essi, anche il “sostegno” alla società civile. È un bene o un male?
Se si sgonfia la bolla della società civile
A prima vista sembrerebbe un male. Ma per alcuni attivisti, quelli che lavorano nei gruppi minoritari, nelle associazioni senza fini di lucro, nelle organizzazioni informali di welfare comunitario, nelle organizzazioni strutturate ma più oneste, la riduzione degli aiuti potrebbe avere conseguenze positive. Per diverse ragioni: perché sgonfierà la “bolla della società civile”, portando i livelli della spesa per gli aiuti allo sviluppo in linea con la capacità di assorbimento della società; perché interromperà il paternalismo dei donatori, che crea dipendenza senza stimolare lo sviluppo; perché potrebbe portare alla politicizzazione di un settore fin qui depoliticizzato; perché potrebbe finalmente rivelare la contraddizione dell’ideologia dell’internazionalismo liberale, quella tra ‘ownership’ e controllo (il tanto sbandierato principio della ‘local ownership’ contraddice infatti la richiesta della comunità internazionale di esercitare il controllo sul processo di ricostruzione). Ma soprattutto perché forse farà emergere quei gruppi che con più consapevolezza cercano di costruire percorsi autonomi, indipendenti tanto dallo Stato e dagli attori politico-militari locali quanto da quelli internazionali.
Non li vediamo, ma questi gruppi ci sono. A volte rivendicano una lunga storia di attività riconducibili all’idea di società civile, anche se espresse in forme diverse da quelle più familiari alla comunità internazionale. Altre volte rivendicano la necessaria maturità per modellare sulla realtà locale, in modo originale e produttivo, un concetto che sanno essere politicamente connotato, ma che non rinunciano a usare. Questi gruppi ci sono e operano concretamente, ogni giorno: organizzano incontri, dibattiti, discussioni; forniscono assistenza al livello comunitario; realizzano campagne di opinione e informazione; rimettono in circolazione le idee, fanno funzionare i circoli letterari e culturali; esercitano pressioni sulla politica affinché si assuma le sue responsabilità.
La coesione sociale e il processo di pace: il vero ambito della società civile
Ma è nel lavoro svolto per la coesione sociale che questi gruppi mostrano le potenzialità maggiori. Tutte le associazioni che operano in questo ambito condividono una diagnosi di partenza: alla base dell’instabilità dell’Afghanistan ci sono molti fattori, ma uno di questi è sicuramente la crisi identitaria – di natura sociale e culturale – che ha investito il paese in seguito a quasi quattro decenni di guerra. Il tessuto sociale che fa di un paese una nazione sarebbe stato fortemente indebolito dalla guerra, causando tra le varie comunità etniche sospetti reciproci non ancora superati (anche perché sfruttati strumentalmente dai politici), fratture non ancora ricomposte. Affrontare l’eredità del passato, ricreare un tessuto sociale condiviso, costruire legami fondati sulla fiducia, evitare i ripiegamenti verso interessi egoistici e circoscritti, rendere le comunità più consapevoli e dunque meno manipolabili dai leader militari che sfruttano le divisioni esistenti: sono questi i compiti che si assegnano questi gruppi. L’obiettivo, spesso implicito, è quello di affiancare al percorso per la “pace politica”, costruita dall’alto al basso dagli attori politico-istituzionali privi di legittimità, una pace sociale, costruita dal basso all’alto dalle comunità locali e dagli attivisti che rappresentano legittimamente interessi sociali ampi. Perché – così sostengono molti attivisti afghani – senza una sottostante pace sociale che gli dia solidità e consistenza, ogni accordo politico è destinato a produrre risultati effimeri: se il dialogo politico-diplomatico è lo strumento più adatto per porre fine al conflitto nel breve periodo, il dialogo sociale, la ricostruzione della fiducia reciproca è invece lo strumento privilegiato per impedire che esploda di nuovo.
Schiacciata tra i barbuti talebani da una parte e un governo corrotto e incapace dall’altra, la società civile afghana può trovare con fatica la sua strada proprio qui, là dove sfugge ai radar della comunità internazionale. Troppo impegnata a fare le valigie per accorgersi che qualcosa di buono si muove anche tra le montagne dell’Hindu Kush.
[1] Le valutazioni appena riportate su tattiche e strategie dei Taliban riprendono uno dei saggi di Antonio Giustozzi, Taliban Military Adaptation, in Theo Farrell, Frans Osinga e James A. Russell (eds.), Military Adaptation in Afghanistan, Stanford University Press 2013.
[2] Carnegie Endowment for International Peace 2013.
[3] Promossa dal network “Afgana” (www.afgana.org), nell’ambito di un progetto che ha ricevuto il sostegno della Direzione generale della Cooperazione allo sviluppo, la ricerca è intitolata “Aspettando il 2014. La società civile su pace, giustizia e riconciliazione”.
[4] Riprendiamo qui alcune delle analisi presentate nella ricerca “La società civile afghana: uno sguardo dall’interno”, promossa da “Afgana” e “Intersos-Link 2007”, con il contributo del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale allo Sviluppo.